È l’ultima finestra ed è quella giusta. L’autunno ha ormai compiuto il suo giro di boa e le ore di luce hanno lasciato il palcoscenico al buio. Qui, la prossima settimana arriva la neve, e questa finestra è destinata a riaprisi solo a primavera.
Il treno scodella tre uomini in bici ai piedi delle Alpi; salire in sella per affrontare il viaggio è l’unico modo per vincere il congelamento. Tarvisio si sveglia con un’aria tagliente da est che si insinua tra le squame della giacca.
Valdi carica le sacche sulla sua rossa corazzata di alluminio da 29 pollici come un milite in partenza per il fronte orientale. Irma con i suoi dolcetti è chiusa, e quindi giriamo alla ricerca di un caldo caffè prima di affrontare il freddo nastro d’asfalto. L’itinerario corre lungo il sedime di quella che fino alla fine del secolo scorso è stata la vecchia ferrovia Pontebbana a binario unico.
Le gambe girano leggere, la pista ci accompagna in dolce discesa. La bici viene inghiottita dal bosco color ruggine, e le ruote sibilano alzando morbidi tappeti di foglie, come fosse il trailer di una favola scritta da Disney.
Giù per la Val Canale e il Canal del Ferro, saltando da una riva all’altra del Fella, fiume dalle acque turchesi. Camporosso, Valbruna, Ugovizza e Malborghetto, lasciando alle spalle l’asburgica Pontafel con il suo storico cippo che segnava il confine tra Italia e Austria fino al 1918. A margine le vette accese dal primo sole: il Lussari, lo Jôf Fuârt, il Mangart, il monte Re e le Ponze.
Il percorso è un continuo alternarsi di luoghi abbandonati: vecchie stazioni, magazzini, manufatti militari e solitarie garitte che raccontano del tempo del confine, della storia che si è fermata alla guerra fredda. Una linea tronca che conduceva nei luoghi di frontiera. Una frontiera desolatamente chiusa.
Il tam-tam delle ruote, che corrono sui vecchi ponti di ferro che incollano le incombenti pareti rocciose, rompe il silenzio che avvolge la vallata. Più in basso lo sfregio arriva dal viadotto autostradale, che taglia come una lama il paesaggio.
A Moggio Udinese la montagna abdica il suo titolo, così come il Fella si concede al più potente Tagliamento e la Cjargne riconfigura la mappa del nostro viaggio.
Da Venzone a Gemona si entra nelle terre del sisma: in quella terribile fragile schiena che in cinquanta secondi ferì a morte la storia di queste valli antiche. Quarant’anni fa il terremoto ha squarciato il duomo e leso campanile e municipio gotico veneziano. Caparbiamente, pietra su pietra è stata rimessa a posto, e la cinta delle mura medioevali salda nuovamente il borgo.
Diversa sorte invece a Portis, qualche chilometro più a nord, dove nella vecchia frazione le case rimaste in piedi non sono più di una ventina, distanziate, dove tra l’una e l’altra è cresciuta una vegetazione incolta che pian piano si riappropria degli spazi lasciati vuoti dagli edifici crollati. Sulle facciate rimaste, evidenti crepe incrociate: quelle che gli esperti chiamano croce di Sant’Andrea e che equivalgono alla condanna a morte dell’edificio.
Le biciclette ora ritornano su sterrati leggeri e, dirette a meridione, lasciano anche Osoppo ai ritmi di un novembre abulico.
A Buja, appollaiato all’unico bar aperto, incontriamo Roberto, che ci racconta vivide leggende di biciclette e pesca, e ci confida con occhi spiritati di un’ orata pescata nel vallone di Muggia, talmente grossa da far fatica a tirarla fuori dall’acqua..
E ancora paesi, villette e campagne, in un continuo ricucire di stradine tra gli orti, e nastri d’asfalto che vomitano camion e macchine come in una frenetica autopista senza fine.
È un alternarsi di lussi e miserie, di case e fabbriche abbandonate e di ville e Suv da capogiro. È l’Italia che va.. è un paese che non comunica più, non condivide: le vecchie osterie lungo la strada oramai ospitano mondi lontani, senza futuro. Sembra che qui nessuno si incontri e dialoghi più.
I colli di Tricesimo ci consegnano alla pianura, la strada si raddrizza sul tavolato che ci porterà in laguna.
Le taccole, tra i campi, rovistano la terra per recuperare le ultime noci da rompere o attaccano le viscere di poveri ricci schiacciati sull’asfalto.
Il cielo si tinge di rosso cardinale per chiudere la messa di un’altra giornata: la pianura ci ingoia nel suo silenzio.
Il viaggio si riconnette nel punto di abbandono, alle porte della Città Granda, di quella calamita al centro della pianura che inevitabilmente catalizza vite e strade.
Ancora il tempo di una pausa e di un caffè preso in piazza, come i gran signori in scarpe lucide e pantaloni inamidati, la quiete del contado è ora rotta dallo sferragliare di masse di uomini e donne in movimento continuo.
Paolo continua a fumare le sigarette degli altri, un modo per convincersi che il desiderio è domato.
Ma la città sta stretta e, come un coltello, la bici la taglia a metà per ritrovare i poderi e le basse casette delle sue frazioni.
Una pianura senza fine, una terra che ti soffoca, fatta di filari pettinati dalla mano di un esperto barbiere. Mulìni le gambe per ritrovare l’orizzonte marino che ti restituisca l’infinito, lo spazio che lo sfilare di campi ti fa apparire più angusto, come il vestito di una taglia più stretta.
Tra casolari, e moderne casette si smarca qualche elegante villa veneta, come Villa Gallici Deciani a Selvuzzis: le ruote ci spingono proprio davanti all’ingresso per poi rispedirci nella campagna verso altri poderi assopiti nel letargo invernale.
Nel mirino ormai abbiamo la fortezza di Palmanova, e accedervi è un po’ come aprire un varco nelle linee nemiche, l’alta murata di pietra ci inghiotte e ci conduce nell’immensa piazza dove possiamo riallacciare le abitudini con un altro caffè, sotto un dolce sole di fine stagione.
Riattivati i motori, l’itinerario si batte con autostrada e linee ferroviarie, tra ciclabili italiche e stradine minori.
Lo sguardo corre costantemente a sud, oltre un tappeto di cotone di nuvole che monta, promettendo futuri giorni d’acqua.
E alla fine, prima del mare, arrivano i canali e le rogge che ci accompagnano in laguna, uno spazio che terra e mare condividono, dove le maree tolgono, ora all’uno ora all’altro, la proprietà dei luoghi.
Lasciata la storia di Aquileia, il piano non inclina più, la tavola si fa biliardo e come una palla da bowling la bici si incanala verso Grado.
E la città del poeta Marin ci accoglie assonnata e spolpa di turisti, come un ricco negozio in liquidazione.
La chiusa è qui, al centro dell’alto Adriatico, nella laguna, tra le barche tirate in secca sullo specchio di un mare fermo color platino, collocati meravigliosamente sulla punta di un immaginario compasso che accoglie tra le sue braccia, nell’ultima lama di sole che illumina lontane le alpi Giulie, il profilo tozzo del monte Nanos, quello acuto del Taiano e la cima aguzza del monte Maggiore in Istria. È il segnale che quest’autunno dolce si congeda così, l’aria densa e fredda che cova oltre le Alpi è pronta a scendere e a coprire le barene di brina. Solo gli storni chiacchierano sugli alberi ormai spogli, come piccoli spettatori di una stagione ai titoli di coda.
Un po’ di foto
[gdl_gallery title=”AlpeAdria” width=”145″ height=”90″ ]





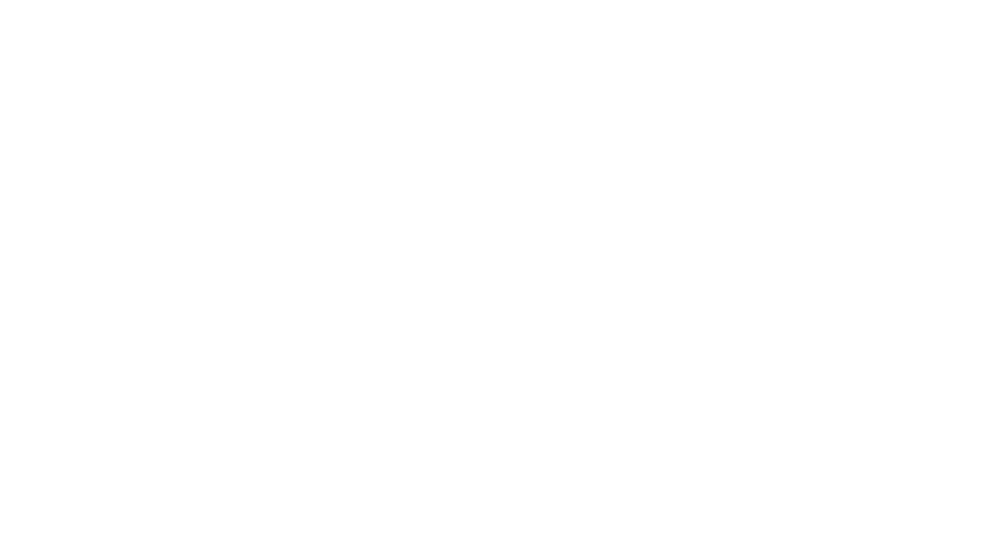
No Comments